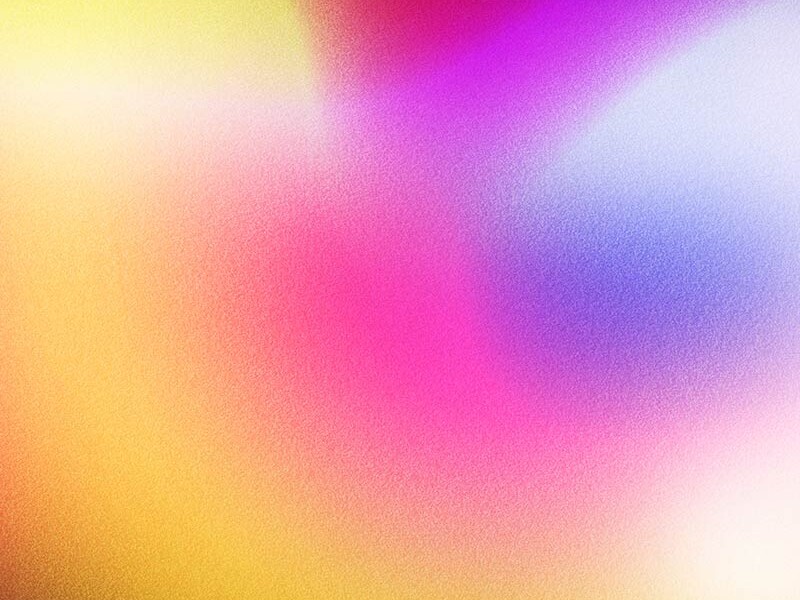Siete pronti per una nuova era del lavoro?
Settembre: voce del verbo “ricominciare”, ovvero il momento perfetto per rimettere sotto la lente un concetto che da anni fa scuola, l’Activity Based Working (ABW). Bello, flessibile, motivante… sulla carta. Ma cosa succede oggi, nel pieno di realtà ibride e generazioni che vivono il lavoro in modo sempre più soggettivo ed emancipato?
L’avete già notato anche voi, qualche crepa si vede. E visto che, come si suol dire “tre indizi fanno una prova”, abbiamo estrapolato tre dati chiave dalla Ricerca Proprietaria Altis che dimostrano perché è il momento di ripensare il modello così come lo conosciamo.

Primo indizio: dalla flessibilità alla dispersione
L’ABW nasceva con una promessa: più libertà, meno scrivanie fisse, più collaborazione. Ma la realtà post-pandemica ci ha restituito un paradosso: il 55% dei Gen Z dichiara di sentirsi solo o in difficoltà a costruire relazioni sociali ( McKinsey). Se l’ufficio non funziona anche come un collante umano, la flessibilità rischia di trasformarsi in dispersione, perché più libertà non equivale automaticamente a più benessere.
Secondo indizio: produttività sì, ma fino a un certo punto
Gli studi sull’ABW mostrano miglioramenti nell’attività fisica e nella soddisfazione, ma anche piccoli cali di produttività. Insomma, ci muoviamo di più, stiamo meglio… ma lavoriamo davvero meglio? È il classico trade-off: l’ambiente favorisce interazione e movimento, ma senza un disegno calibrato sulle persone, rischia di rallentare i processi invece di accelerarli.
Terzo indizio: il ROI non è più solo immobiliare
Per anni l’ABW è stato adottato per ridurre le postazioni e ottimizzare i metri quadri. Oggi, però, parlare di ROI significa guardare oltre l’occupancy: salute mentale, engagement, qualità delle interazioni. In un mondo ibrido, il vero valore dello spazio non è “quante scrivanie risparmi”, ma “quante connessioni generi”.
La prova: un passo avanti con l’EBW
Ecco perché in Altis parliamo di Emotional Based Working. Non un semplice acronimo da proporre all’Accademia della Crusca, ma un approccio solido, basato sui dati e sulle persone. Alla base c’è la nostra Ricerca Proprietaria, che esplora la relazione tra spazio e comportamento, indagando come l’ambiente fisico influenzi lo stato emotivo e le dinamiche sociali all’interno di un ufficio. È così che ogni progetto si fonda su evidenze scientifiche e su una reale comprensione di come lo spazio possa migliorare benessere e produttività.
Perché il lavoro di oggi è basato sulle emozioni piuttosto che sulla sola attività. Ed è tempo di progettare luoghi che lo riflettano, senza nostalgia per i vecchi modelli, e cogliere un’importante intuizione: il prossimo “upgrade” del lavoro non sarà solo tecnologico, ma anche emotivo.
Il resto della storia? Scriveteci a [email protected]. Ve la raccontiamo. [email protected]. We’ll tell you more.
Quando l’architettura smette di assecondarci
Siamo abituati a pensare allo spazio come a un alleato fedele: ti accoglie, ti protegge, ti facilita la vita. È la narrazione dominante dell’architettura contemporanea: “user-friendly” e “human-centred”. Ma se invece così non fosse? Se l’architettura fosse anch’essa piena di limiti, costrizioni e compromessi?
Per poi scoprire che forse è proprio lì che si apre un varco creativo.

Lo spazio non è nostro schiavo
Abbiamo chiesto agli edifici di essere sempre più accomodanti: silenziosi quando serve concentrazione, flessibili quando serve collaborazione, persino “emozionanti” dai render in poi. Ma questa rincorsa all’architettura-servizio rischia di diventare sterile. Uno spazio efficace non è per forza una entità servizievole: a volte è un interlocutore. Che esprime un'opinione, o ci invita ad esperire una forma diversa dell’abitare. Pensiamo alle scale del MAXXI di Roma, o alla loft-mania che ha riqualificato l’intero quartiere di Soho a Manhattan. Spazi servizievoli? Tutt’altro. Spazi utili? Assolutamente si. Una costruzione può obbligarci a immaginare soluzioni diverse. E anche in questo può stare il suo valore.
L’attrito come risorsa
Un corridoio troppo stretto, un’ombra che cade sempre nel punto sbagliato, un materiale che invecchia più in fretta del previsto: fastidi? Forse. Ma anche stimoli. Perché l’attrito non è solo disagio: è la resistenza che ci costringe a muoverci, a cambiare traiettoria, a inventare nuove soluzioni. Abitare è sempre negoziare: se vogliamo il parquet di rovere, sappiamo che per forza si rovinerà col tempo. Non esiste altra soluzione fra materiale naturale e vita quotidiana: quel materiale porterà i segni del nostro passaggio.
Contro l’illusione del “tailor-made”
Viviamo nell’epoca della personalizzazione estrema, ma lo spazio non deve sempre replicare questa logica. L’illusione del “su misura” totale rischia di ridurre l’architettura a un’applicazione di comfort. Un ufficio che non ci coccola in ogni momento può diventare invece palestra di resilienza, stimolo a confrontarsi, terreno fertile per conflitti che generano nuove idee.
Non si tratta di una rinuncia alla funzione, ma un’apertura al conflitto creativo. Accettare che lo spazio non ci appartenga del tutto, che sia qualcosa con cui dobbiamo dialogare, anche scontrarci, significa restituirgli dignità e profondità. Perché è dal confronto che nascono le trasformazioni più radicali.
La mappa non è il territorio (ma ci aiuta a capirlo bene)
Lo diceva Gregory Bateson, padre del pensiero sistemico: “la mappa non è il territorio”. Ma senza mappe ci perdiamo: anche se non coincide con la realtà, la mappa, per definizione, è quella che ci permette di leggerla e interpretarla. E di muoverci al suo interno con consapevolezza. Il nostro lavoro in Altis non è solo disegnare un ufficio esteticamente bello, ma costruire strumenti che aiutino a orientarsi in uno spazio sempre più complesso, fatto di persone, comportamenti, regole, budget, emozioni…
"Consult-design-deliver": il metodo step by step di Altis, che non si limita al “progetto”, ma accompagna il cliente dall’ascolto fino alla consegna con la certezza che se si vuole trasformare davvero un ambiente di lavoro, non basta il rendering. Serve una mappatura intelligente, accessibile e rigorosa.

Pensiero sistemico: prima capiamo come funziona, poi cosa fare
Ogni spazio di lavoro è un ecosistema vivo. Non esiste un cambiamento isolato: se sposti il layout, cambiano i flussi; se cambi i flussi, cambiano i comportamenti; se cambiano i comportamenti, si trasformano performance, costi e perfino cultura aziendale. È l’effetto domino del lavoro contemporaneo. Per questo partiamo sempre da una lettura sistemica. Chiedere solo “quanti metri quadri vi servono?” risulta quindi riduttivo, epistemologicamente scorretto, per dirla come il maestro.
Fase 1: CONSULT — Osservare il territorio
La fase di Consult è la nostra esplorazione del territorio, dove raccogliamo dati. Kick-off e Needs Analysis ci servono per inquadrare sfide e opportunità. L’Occupancy Study ci dice chi usa cosa, quando e come. Con il Rapid Prototyping testiamo soluzioni in piccolo per trovare conferme in grande. E con la Building Analysis & Test-Fit capiamo che cosa è davvero realizzabile, rispettando ogni tipo di vincolo tecnico e normativo. Alla fine tutto confluisce nel Business Case, non il classico documento ma una bussola: ti dice dove ha senso investire, dove ridurre e come distribuire le risorse in modo intelligente.
Fase 2: DESIGN — Disegnare la mappa, modellando i comportamenti
Il Design non serve a rendere bello un ambiente: serve a fare nudge dei comportamenti desiderati. Il Concept Design traduce valori e obiettivi in linee guida concrete. Il Design Development affina le scelte, mentre il Technical Design le rende “cantierabili”. L’arredo non è scenografia: è strumento funzionale che orienta pratiche quotidiane. In parallelo, il Progressive Budgeting rende trasparente l’evoluzione dei costi: niente sorprese finali, ma scelte progressivamente misurate. Infine, il Contract definisce gli accordi in modo chiaro: budget, tempi e responsabilità. Qui la mappa è pronta, ed è dettagliata: non un’utopia, ma un documento operativo che tiene insieme estetica, funzione e sostenibilità economica.
Fase 3: DELIVER — Dal cantiere alle persone (con un controllo puntuale)
La fase di Deliver è quella in cui la mappa guida la costruzione del nuovo territorio. Qui non basta “costruire bene”: serve controllo continuo e capacità di gestire complessità. Permessi, procurement, sicurezza, costruzione, logistica dei traslochi: ogni passaggio viene monitorato con un controllo progressivo dei costi, che permette di intervenire subito in caso di deviazioni. C’è poi il tema più spesso trascurato: il Change Management. Perché gli spazi non cambiano nulla se le persone non li abitano diversamente. Comunicare, accompagnare, ascoltare: sono leve progettuali tanto quanto una parete divisoria o una scrivania regolabile.
Funziona? I dati dicono di sì.
Il metodo Altis funziona perché rompe lo schema tradizionale “a silos”: consulenti che passano la palla ai progettisti, che la passano agli acquisti, che infine la danno al general contractor. Ogni passaggio fa perdere tempo, informazioni e controllo. Noi uniamo tutto in un processo end-to-end, in cui i dati raccolti in fase di analisi restano vivi fino alla consegna finale. Il risultato è misurabile: tempi ridotti fino al 25%, budget rispettato, meno rischi. Ma soprattutto, progetti che hanno senso non solo sulla carta, ma nel quotidiano delle persone che li abitano.
Il metodo Altis nasce per accompagnare la complessità: ascoltare, modellare, testare, consegnare. Un passo alla volta, con le persone al centro. Se volete vedere la nostra mappa applicata al vostro territorio, scriveteci a: [email protected]