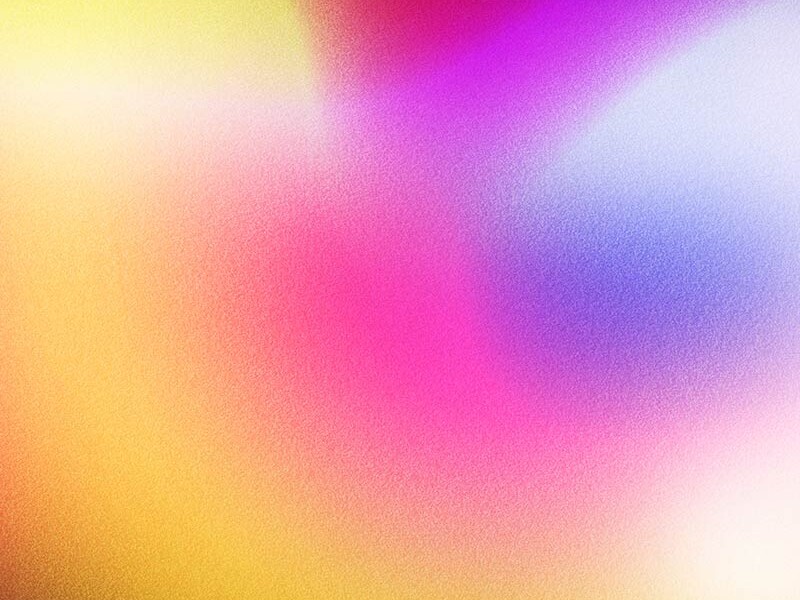La finestra come orizzonte
Se chiedessimo ad Alfred Hitchcock la sua idea di finestra, probabilmente non si soffermerebbe sull’estetica quanto piuttosto sulla percezione. In “Rear Window” (“La Finestra sul cortile”, 1954) la finestra diventa un varco narrativo: racconta l’ossessione del guardare fuori e l’illusione che ci sia sempre una vita più interessante dall’altra parte del vetro.
E noi, quanto tempo passiamo a guardare fuori dalla finestra? Un gesto universale, che sa di respiro e di libertà, che compiamo per ritagliarci un momento di pausa e di evasione. La finestra, in ufficio come a casa, non è un semplice infisso, è un comando emotivo: il nostro Ctrl+Alt+View. Uno strumento che cambia il modo in cui lavoriamo, pensiamo e ci percepiamo.

L’affaccio come palestra mentale
Il punto è che guardare fuori interrompe la spirale del multitasking e apre uno spazio nuovo. Neuroscienze alla mano: l’affaccio riduce i livelli di cortisolo, stimola la creatività laterale e abbassa la percezione dello stress. Non è un vezzo, ma biochimica. Non a caso le aziende che investono in uffici panoramici ottengono risultati migliori in engagement e performance.
Dal corner office al seminterrato
Ma non tutte le finestre sono uguali. Lo sappiamo: c’è chi si affaccia su skyline da cartolina e chi si ritrova con vista parcheggio o muro di cemento. Eppure, anche qui il cervello fa la sua parte. Qualsiasi collegamento visivo con l’esterno, persino un albero spelacchiato o un corvo sul cornicione, funziona da reminder che il mondo va avanti anche oltre l’Excel che abbiamo davanti agli occhi. E non conta solo il panorama, ma la possibilità di avere un orizzonte, di percepire l’oltre (lo sappiamo, suonerà New Age… ma ha tutta la sua logica).
Quando la finestra non c’è
Se di finestre non ce ne sono, allora l’occhio se le inventa: un graffito sulla parete, uno screensaver tropicale, persino un corridoio illuminato diventano orizzonti sostitutivi. Funzionano? Fino a un certo punto. Senza accesso alla luce naturale e al contatto visivo con l’esterno, la produttività cala e il benessere psicologico si riduce drasticamente. Per questo il tema non è estetico, ma progettuale: ripensare i luoghi di lavoro significa anche decidere come e dove aprire finestre.
La finestra, insomma, è molto più che uno sguardo sul mondo: è un’interfaccia tra dentro e fuori, tra concentrazione e fuga, tra quotidiano e sogno. Non risolve tutti i mali del lavoro contemporaneo, certo. Ma resta un elemento fondamentale del nostro wellbeing quotidiano. Per il resto, vale la lezione di Hitchcock: il fuori che osserviamo è solo un pretesto, perché la vera scena si svolge sempre dentro di noi.
Il cantiere invisibile
Ogni progetto architettonico ha due facce: quella che appare, fatta di forme e materiali, e quella che resta dietro le quinte. Non parliamo di gru e caschetti, ma di quella zona grigia fatta di permessi, incastri logistici, convivenza di squadre di lavoro e gestione degli imprevisti. È il lato invisibile del costruire: quello che non compare nei rendering ma che decide le sorti del progetto.

La burocrazia non è un dettaglio (Ma dai?)
Altro che cemento armato: il vero muro iniziale è fatto di carte bollate, autorizzazioni, normative. Non il pezzo più glamour, certo, ma senza quello il resto non parte. E qui non basta compilare moduli: serve leggere le pieghe del sistema, anticipare le frizioni, usare i vincoli come bussola. In altre parole: il backstage legale è già parte del progetto.
Logistica: il Tetris che nessuno immagina
Un cantiere non è solo costruzione: è una coreografia di materiali, attrezzature e persone. Quando la logistica funziona, nessuno se ne accorge; quando non funziona, tutti se ne ricordano. Il dietro le quinte è un esercizio di sincronia: coordinare fornitori, gestire ingressi, rispettare orari. Un’arte meno tangibile, ma decisiva.
Gli imprevisti non sono imprevisti
In teoria sono ostacoli, in pratica sono la normalità. Ritardi, errori di fornitura, imprevisti strutturali: ogni cantiere li conosce. La differenza la fa la preparazione. Leggere i vincoli in fase di progetto, anticipare le criticità e governarle fino alla consegna è ciò che distingue un approccio meno organizzato da un metodo solido. Noi lo chiamiamo Consult – Design – Delivery ed è efficace perché mette in sequenza ciò che di solito resta scollegato: leggiamo i requisiti reali e le regole del contesto prima di disegnare, progettiamo scelte che semplificano la logistica e riducono gli intoppi, e in consegna coordiniamo tempi, attori e imprevisti come un’unica regia.
Se volete scoprire come Altis tiene insieme il volto visibile e invisibile di ogni progetto, scriveteci a [email protected]
Open Plan, Closed Minds?
Sedie che si girano, scrivanie senza confini e la promessa di un brainstorming perenne. Così è stato venduto l’open space: la soluzione definitiva per rendere le aziende più collaborative, dinamiche, “cool”. E invece? Nella realtà la colonna sonora è fatta di rumore, distrazioni, telefonate in vivavoce e cuffie noise-cancelling come unica forma di autodifesa.
L’open space è diventato lo standard, ma non per questo funziona sempre. Anzi… spesso è vero il contrario.

Il mito della collaborazione perpetua
Negli anni Novanta e Duemila, gli open space hanno incarnato un’idea quasi utopica di ufficio: nessun muro, nessuna barriera, solo colleghi pronti a condividere idee come se fossero caramelle. In teoria, la formula sarebbe: più prossimità = più collaborazione. In pratica, più prossimità = più pausa caffè e chiacchiera. Il mito dell’interazione spontanea si è spesso trasformato in una trappola: l’open plan non garantisce scambio, ma interruzioni.
Rumore bianco o rumore nero?
Il problema non è solo organizzativo, ma cognitivo. Ogni interruzione spezza quelli che possiamo chiamare “cicli attentivi”: uno studio recente di Toggl Blog segnala che servono in media 23 minuti per recuperare la concentrazione persa dopo una distrazione. Moltiplichiamolo per dieci micro-distrazioni al giorno ed è chiaro perché i phone booth sono diventati lo status-symbol dell’open space. La promessa di energia collettiva si trasforma facilmente in rumore bianco, quando va bene, o in rumore nero, quello che brucia tempo e pazienza.
Non open vs closed, ma plural
Il punto non è scegliere tra muri o spazi aperti. La questione è più sottile e sta nel progettare spazi che rispettino i diversi registri cognitivi ed emotivi delle persone: c’è chi ha bisogno di isolamento per concentrarsi, chi di condivisione per generare idee, chi di movimento per trovare energia.
Qui entra in gioco il nostro approccio Emotion Based Working: leggere e progettare gli spazi a partire dalle emozioni che devono sostenere, non dal dogma architettonico del momento. Non esiste un modello unico, ma un ecosistema di possibilità. Stanze chiuse, aree ibride, angoli di privacy, zone fluide: il vero ufficio non è un dogma spaziale, ma un insieme di scelte consapevoli.
Vogliamo accettarlo o no?
L’open space è stato il simbolo di un’epoca, probabilmente passata. Lavorare bene ora significa costruire ambienti che sanno quando aprirsi e quando chiudersi. Perché, alla fine, la vera collaborazione va al di là dalla disposizione delle scrivanie: nasce dalla progettazione di uno spazio che rispetti i diversi modi di pensare e di lavorare.
Se questo tema vi intriga, scriveteci a [email protected], vi promettiamo una conversazione più stimolante di un brainstorming improvvisato davanti alla macchinetta del caffè.