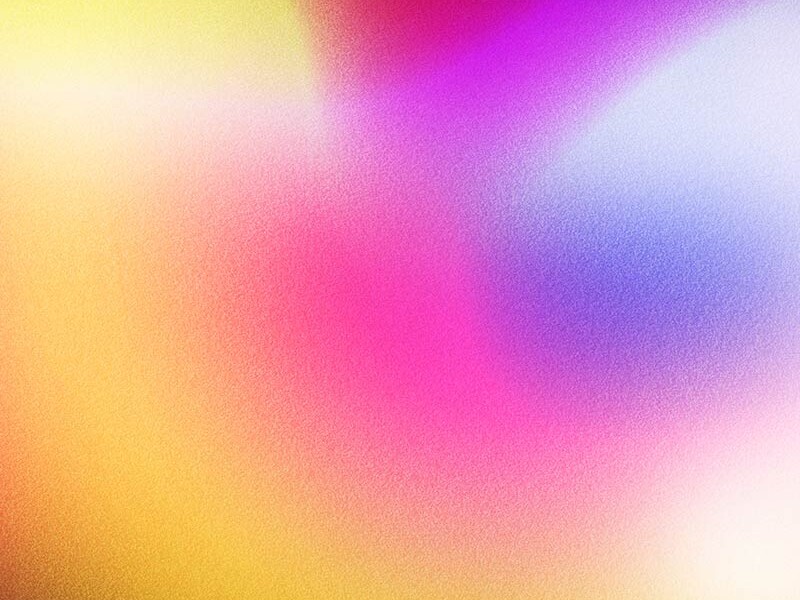Viviamo nel mondo del full. Full optional, full time, fully booked. Ma è davvero una conquista o piuttosto una sottile condanna? Nell’ossessione collettiva di saturare ogni centimetro, fisico o mentale che sia, abbiamo dimenticato cosa significhi lasciare spazio. Eppure, il vuoto non è un errore di progettazione: è una scelta consapevole.
In architettura, il vuoto è quella pausa che permette allo sguardo di muoversi, al corpo di respirare, alla mente di pensare. Fuori dall’architettura, il vuoto è la condizione di possibilità di ogni cosa: pensiamo anche alla musica, dove senza pause e silenzi non avremmo melodie ma solo cacofonie indistinte.
E sì, lo sappiamo: questo non è il classico articolo da leggere velocemente tra un meeting e l’altro. È piuttosto un invito: nei prossimi paragrafi, cammineremo insieme in questo spazio indefinito con quattro suggestioni diverse, dall’arte alla filosofia, dalla musica al senso di cura, per scoprire che il vuoto, forse, è più pieno di quanto immaginiamo. Come dice Isabella Ducoli, Head of Design Altis: “In architettura, il vuoto non è assenza: è possibilità. È l’unico spazio che non devi riempire per forza, ma che ti chiede di essere attraversato.”

1. Rachel Whiteread: la scultrice dell’invisibile
Rachel Whiteread, artista britannica, ha trasformato letteralmente il vuoto in materia. Le sue opere sono calchi del vuoto: riempie di resina o cemento gli spazi che normalmente restano invisibili come l’interno di una casa, di una vasca da bagno, di una libreria, restituendoci il negativo come scultura. Come a dirci che il vuoto è un pieno capovolto. Un pieno che parla di chi c’era, di cosa conteneva, di vite intere che si sono mosse dentro quei volumi. Perché, senza vuoto, nessuno spazio sarebbe davvero abitabile: non potremmo attraversarlo, viverlo, agirlo.
2. Gordon Matta-Clark: tagliare per vedere
Poi c’è Gordon Matta-Clark, architetto e artista americano degli anni Settanta, famoso per i suoi tagli radicali negli edifici abbandonati. Ne bucava le pareti per rivelarne l’interno, creando enormi ferite architettoniche che diventavano nuovi spazi di luce e di esperienza. Per Matta-Clark, il vuoto era un gesto politico: rivelava cosa c’era dentro, metteva a nudo l’essenza delle cose, e di noi stessi. A questo proposito, Isabella Ducoli commenta:“Il vuoto è un campo attivo. È ciò che succede quando togli il superfluo e lasci solo lo spazio per ciò che conta.”
3. John Cage: il suono del silenzio
Ma non bisogna per forza sporcarsi le mani di calcestruzzo o impugnare una sega circolare per capire il vuoto. John Cage, compositore americano, ci ha insegnato che anche il silenzio è pieno di suono. Nel 1952 compose 4’33”, un brano in cui l’esecutore non suona alcuna nota. Sono quattro minuti e trentatré secondi di apparente silenzio in cui, in realtà, si ascolta tutto: i colpi di tosse, le sedie che scricchiolano, la pioggia sul tetto, il respiro di chi è in sala. Cage ci ricorda che il vuoto è sempre pieno di qualcosa: basta saperlo ascoltare.
4. La prospettiva Altis: il vuoto come cura
Se tutto intorno a noi è ipersaturo, il vuoto si presenta come un gesto radicale di cura. Vuoto come digital detox, come spazio mentale, come atto progettuale che rinuncia al superfluo per lasciare ciò che conta davvero: aria, luce, respiro. È la piazza tra i palazzi, che non è solo un interstizio urbano ma un luogo di incontro e socialità. È la radura nel bosco sacro, che nelle tradizioni scintoiste giapponesi diventa cornice per il divino, spazio sacro proprio perché vuoto. È il giardino Zen, che non offre nulla di superfluo se non la sua stessa essenzialità, e proprio per questo diventa metafora di contemplazione e meditazione.
Parlare di vuoto come cura significa riconoscere che non abbiamo bisogno di riempire ogni spazio per farlo esistere. Anzi, il vuoto è la riserva di possibilità, il campo di tutte le trasformazioni potenziali. E soprattutto, come ci racconta Isabella: “Il vuoto è l’ultimo lusso rimasto: uno spazio che non devi giustificare, che esiste per farti esistere meglio.”