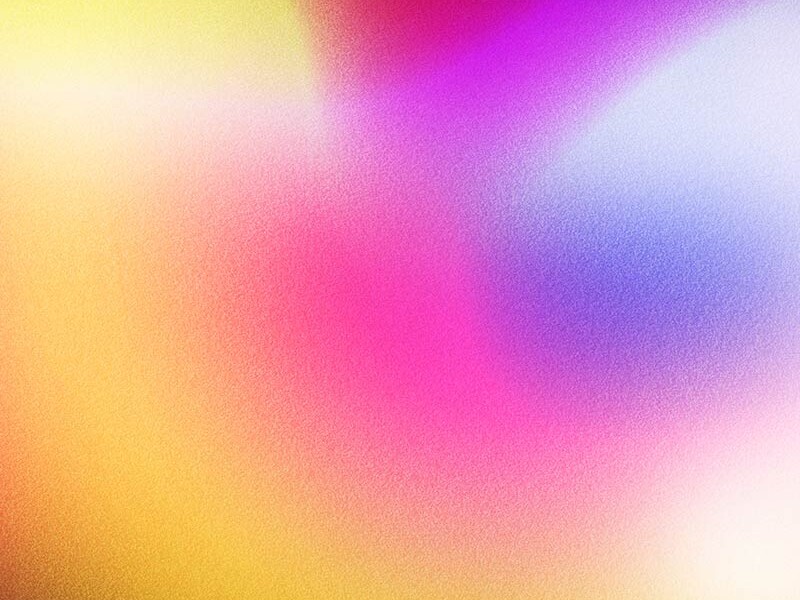Holiday Mindset: quando la tua mente si accorge che è dicembre
A dicembre succede qualcosa che non ha nulla a che fare con le decorazioni, i panettoni, o l’algoritmo dei regali. E questo qualcosa succede nella tua testa. Le neuroscienze parlano di anticipatory cognition: il cervello, in prossimità di una transizione, modifica attenzione, motivazione e percezione dell’ambiente circostante. Nella psicologia del benessere compare anche l’anticipatory relaxation response: quando il corpo si rilassa prima ancora di essere davvero in uno stato di pausa. È ciò che accade ogni fine anno con quell’holiday mindset misurabile e ricorrente che vede un leggero scollamento dalla routine, da intendere non come distrazione, ma come necessità neurocognitiva. La mente si mette comoda, un po’ come quell’albero pieno di palline e luci nel tuo salotto.

Quando l’attenzione vacilla
Non ci accorgiamo più dei dettagli abituali come il collega che parla a voce alta, ma notiamo all’improvviso cose che ignoravamo nel quotidiano: il rumore ovattato del corridoio, la sensazione di stacco quando chiudiamo il laptop. Possiamo ricondurre tutto alla neurobiologia. Quando il cervello percepisce una soglia imminente, taglia il superfluo e mette a fuoco l’essenziale. Per questo possiamo consacrare dicembre come un mese selettivo: salva ciò che davvero conta e ti lascia con la promessa del “ne riparliamo a gennaio”. E paradossalmente, è proprio questa selettività a rendere più confuso il celebre rush finale: tentiamo di chiudere tutti i task, ma la mente, impegnata a preparare la transizione, non segue più una linea retta. È come lavorare con un calendario dell’Avvento incorporato: ogni giorno apre una casella, e una porzione di attenzione se ne va altrove.
Il workplace in dissolvenza
Osservare un workplace a fine anno è un esperimento di economia cognitiva interessante: le soste si fanno più frequenti, le conversazioni più leggere. Sono gesti che compiamo quando qualcosa sta per finire: attraversiamo gli ultimi scampoli con un piede nel presente e l’altro già nell’altrove. Il workplace, così, si trasforma in un set di microfasi che ci dettano un’andatura, di passo e pensiero, tutta loro.
Dicembre è questo: un mese in cui la mente prepara la coreografia, alleggerisce la trama e sistema gli oggetti di scena. E quando arriva il momento, noi inconsapevolmente siamo già pronti. A fare cosa? Bè, alle maratone a tavola e a riguardare Una poltrona per due come se fosse sempre la prima volta. Trading Places as if it were the very first time.
Dietro le quinte della case history JPMS
“JPMS è stato prima di tutto un esercizio di convivenza fra due diverse entità”. Così esordisce Isabella Ducoli, Head of Design Altis, parlando della nuova sede romana di JPMS, gruppo internazionale del settore haircare.
Da un lato c’era un’accademia di formazione: corsi per parrucchieri, workshop, brand experience, dimostrazioni tecniche. Dall’altro, gli uffici operativi: marketing e team corporate. “Ci chiedevano un unico spazio per due funzioni che, di fatto, richiedono atmosfere e logiche cognitive diverse, all’interno dello stesso edificio”.

Le criticità: un edificio promettente, ma contraddittorio
L’immobile aveva un grande potenziale con tre accessi indipendenti, ma anche nodi progettuali importanti:
- un solo corpo bagni, insufficiente per due funzioni autonome;
- un’area centrale molto profonda, difficile da organizzare;
- un nucleo, occupato da impianti e locali tecnici, pieno di elementi eterogenei e discontinuità visive;
- due viste differenti, una ampia sulla piazza e una schermata sulla corte interna.
“Era uno spazio bello ma disordinato,” racconta Isabella. “Avevamo tanti elementi che tiravano in direzioni diverse. L’obiettivo era farli lavorare insieme.”
La strategia progettuale Altis: tre mosse che fanno sistema
La prima mossa è stata quella più strutturale poiché riguardava il cuore dell’edificio: creare un nuovo corpo bagni per garantire le due funzioni, formativa e operativa, senza interferenze.
“L’edificio era molto profondo: serviva un secondo nucleo per dare autonomia a academy e uffici. È stata una scelta tecnica, ma soprattutto organizzativa.” Con questo intervento, le due entità trovano finalmente una distribuzione coerente.
La seconda mossa riguardava l’organizzazione delle viste e la loro fruizione come vera matrice del progetto. “La vista sulla piazza era splendida: luce, profondità, orizzonte. Gli uffici dovevano stare lì. Al contrario, l’accademia non aveva bisogno di panorama essendoci i prodotti, gli schermi e l’esperienza formativa.” Per schermare la corte interna, poco valorizzante, Altis utilizza un sistema continuo di piante integrate che filtra la luce e migliora la qualità percettiva dello showroom.
Infine, il nodo più complesso era il core tecnico centrale: irregolare, visivamente caotico, interrotto da porte, impianti e segnaletiche. Isabella lo ricorda bene: “Era un punto che necessitava di ordine. Così abbiamo pensato a un elemento che non fosse solo estetico, ma efficiente.”
Nasce così la Brand Gallery, un volume unico che corre a tutta altezza lungo il perimetro del core. Una soluzione che:
- riordina il nucleo nascondendo impianti e discontinuità;
- funziona da storage continuo per entrambe le aree;
- si apre nei punti strategici per diventare un vero showcase dei prodotti JPMS;
- collega idealmente academy e uffici, diventando una spina dorsale narrativa e operativa.
“Era tutto molto frammentato. La gallery è diventata l’elemento che mette ordine e racconta il brand.”
Il risultato: un progetto che tiene insieme due mondi
JPMS oggi è uno spazio coerente, dove funzioni, percezioni e ritmi diversi dialogano senza conflitti. È un caso in cui il metodo Altis mostra come i vincoli possano diventare struttura, e come la narrativa spaziale interna possa trasformare un problema distributivo in un’identità progettuale forte.
Se vuoi conoscere l’approccio giusto per il tuo spazio, scrivici a [email protected] [email protected].
Oltre l’umano-centrico: progettare per l’AI e l’Era delle Macchine
Per anni abbiamo progettato spazi a partire dall’umano, valutando posture, bisogni, emozioni. Ma oggi nei workplace è entrato un nuovo attore: l’intelligenza artificiale. Non sostituisce le persone, ma moltiplica le loro interazioni e ne altera le velocità. Non siamo più soli nella stanza. Siamo in due: una mente emotiva e una algoritmica, che lavorano secondo logiche temporali e operative molto diverse. E anche questo, certamente, ha un impatto progettuale. La domanda diventa allora: cosa succede allo spazio quando due diverse intelligenze ci convivono?

Dai laboratori del futuro alle scrivanie del presente
È il tema affrontato anche da Gensler nel suo studio sui “next labs”. Dal biotech alla robotica, i laboratori stanno diventando ibridi: processi automatizzati accanto a decisioni umane, dati in tempo reale che cambiano il workflow, ecosistemi di intelligenze diverse che condividono lo stesso ambiente operativo. Quello che accade nei laboratori oggi, accadrà negli uffici domani.
Ed è qui che il metodo Altis trova un ruolo cruciale: leggere l’intreccio tra comportamenti, processi e spazi, e tradurlo in un progetto che non favorisca la macchina né la persona, ma la relazione tra le due entità.
Progettare per una doppia intelligenza
Ecco i nuovi elementi progettuali che entrano in gioco creando ambienti in cui le due velocità possano coesistere:
- Buffer cognitivi Interfacce spaziali che regolano il flusso informativo tra umano e macchina: stanze di transizione, zone di decantazione decisionale, aree dove “rallentare” l’automazione a favore del giudizio umano.
- Soglie di attenzione Percorsi che separano momenti ad alta intensità computazionale da momenti ad alta intensità emotiva. L’AI segnala, suggerisce, prevede; l’umano integra, valuta, modula. Paths that separate moments of high computational intensity from moments of high emotional intensity. AI signals, suggests, predicts; humans integrate, evaluate and modulate.
- Ritmi asincroni Spazi progettati per lavori che non seguono più un’unica metrica temporale: il tempo biologico (pausa, postura, riposo), il tempo algoritmico (calcolo continuo). Serve un design che armonizzi i due cicli, evitando il sovraccarico.
- Interfacce umane Aree in cui la tecnologia non domina, ma dialoga: schermi che informano senza invadere, sistemi predittivi che non interrompono, ambienti dove il digitale resta leggibile e governabile. Areas where technology does not dominate but converses: screens that inform without overwhelming, predictive systems that do not interrupt, environments where the digital remains legible and governable.
Il metodo Altis come mediatore
Quando i processi diventano ibridi e le decisioni si muovono su due frequenze, serve una postura progettuale. Con il suo Metodo in tre step Consult, Design, Deliver, Altis si rivela il framework ideale per governare questa coabitazione. Un approccio che protegge l’umano, traducendo la complessità in un ecosistema coerente, leggibile, abitabile. Perché mentre il lavoro accelera sul virtuale e sulle logiche dell’AI, la dimensione collettiva tende ad assottigliarsi. Lo spazio fisico diventa allora il contrappunto necessario: il luogo che ci ricorda che, per funzionare, continuiamo ad avere bisogno gli uni degli altri.
Se questi pensieri appartengono anche al tuo workplace, scrivici a [email protected]: alcune conversazioni meritano di prendere forma.
Il comfort dei limiti
C’è una strana forma di pace nei limiti. Forse perché ci ricordano che tutto, perfino il senso di libertà, ha bisogno di una forma. In architettura come nella vita, i vincoli non sono solo barriere, ma ciò che permette al pensiero di diventare progetto: il muro che definisce lo spazio, la regola che guida la creatività, il tempo che impone una fine. Pensavamo fosse costrizione, invece è questione di ritmo.

Il limite come cornice
L’architetto e designer finlandese Alvar Aalto diceva che l’architettura nasce dal rispetto per il materiale, e che il materiale, per sua natura, impone un limite. Pensiamo alla curvatura possibile del legno, la resistenza del mattone, la trasparenza del vetro. È proprio la materia, con le sue regole e la sua resistenza, a trasformare l’idea in forma. Lo stesso vale per la mente: le neuroscienze mostrano che un numero finito di possibilità favorisce il focus e abbassa lo stress decisionale. Troppe opzioni, troppe aperture, e il cervello va in tilt. Il limite, allora, diventa un alleato cognitivo: la condizione che ci permette di scegliere, ordinare, creare.
Contenere per respirare
E se si trattasse di ribaltare la prospettiva? Viviamo in una cultura che ci chiede costantemente di espanderci: produrre di più, connetterci di più, aprirci sempre di più. Eppure il vero benessere nasce spesso dal contenimento. Come in un giardino zen giapponese, dove il confine non chiude ma orienta lo sguardo, anche gli spazi di lavoro possono essere pensati come ecosistemi limitati ma generativi: non tutto ovunque, ma il giusto dove serve. Applichiamolo a un pensiero potenzialmente diffuso come “ah, che bello, adesso lavoro dal divano”. Ma poi da quel divano ci lavorate bene, davvero? La libertà totale funziona solo finché esiste un contesto che la contiene: un frangente di tempo, una postura, una soglia che distingue il lavoro da quello che non lo è. Contesto significa vincolo ( = alcune cose posso farle, altre no) e proprio per questo posso concentrarmi, produrre, per poi respirare.
La misura è un atto creativo
C’è della bellezza nel progettare con misura: decidere dove fermarsi, quanto spazio lasciare, quanto tempo dedicare. È un gesto etico prima ancora che estetico. Il limite diventa un segno di cura, una soglia che protegge in primo luogo noi stessi.
E forse il vero lusso, oggi, è abitare dentro un perimetro pensato: uno spazio che non ci spinge verso l’infinito, ma che ci invita a ritrovare la nostra personale forma di raccoglimento. Ripetiamo insieme: la libertà assoluta disorienta, il limite accoglie.
La scienza dell’appartenenza
In una scena di Will Hunting - Genio Ribelle (1997) un intenso Robin Williams, nei panni dello psicologo, dice a un giovanissimo Matt Damon:
“You’re afraid of what you might become if you let someone in.” Hai paura di cosa potresti diventare se lasci entrare qualcuno.
Non è, solo, una battuta che si riferisce a un genio difficile da domare. È una frase che parla di fiducia: di quanto sia complesso concederla, aprirsi, trovare il proprio spazio. Sul lavoro succede di frequente. Ci muoviamo tra team, call, progetti condivisi, eppure spesso rimaniamo ai margini emotivi di ciò che costruiamo. Perché appartenere significa lasciarsi vedere con la propria voce, vulnerabilità e presenza, ma non sempre siamo disposti a farlo.

Più che empatia: sicurezza psicologica
Ed ecco che torna utile il concetto di psychological safety, coniato nel 1999 da Amy Edmondson, docente di Leadership and Management ad Harvard: la convinzione che un gruppo funzioni meglio quando ognuno si sente libero di esporsi, sbagliare, proporre. Sicurezza, non comfort: non si tratta di eliminare il rischio, ma di creare un contesto in cui il rischio sia sostenibile. Dove la fiducia diventa una piattaforma, più che una promessa. Perché se la paura di essere giudicati blocca l’espressione, la sicurezza di poter contribuire la moltiplica. È proprio da questa consapevolezza che nasce Emotion Based Working (EBW), l’approccio sviluppato da Altis per progettare spazi a partire dalle emozioni che devono sostenere. EBW traduce in metodo ciò che spesso resta intangibile: la relazione tra architettura e stati emotivi. Costruire luoghi in cui sentirsi parte, dunque, significa dare forma a fiducia, empatia e identità condivisa.
Misurare l’imponderabile
Ma quindi si può misurare il “sentirsi parte”? Più o meno, sì. Le neuroscienze parlano di ormoni come ossitocina e dopamina; la psicologia, di motivazione; il marketing di engagement. Ma il vero indicatore resta umano: la disponibilità spontanea a restare, contribuire, prendersi cura. Nei progetti di Altis questo si traduce in spazi che favoriscono l’incontro, ma anche il riconoscimento individuale. Zone comuni, sì, ma anche nicchie personali: perché l’appartenenza collettiva si costruisce solo se ognuno trova il proprio posto, fisico ed emotivo.
Appartenere, in fondo, non è uno stato. È un verbo in continua coniugazione. Un lavoro quotidiano, silenzioso, di cura del contesto. Perché nessun open space, da solo, basta a farci sentire parte di qualcosa, ma uno spazio pensato per le persone può ancora farci dire, con sincerità, “qui sto bene”.
È una riflessione che senti anche un po’ tua? Contattaci a [email protected] e parliamone insieme.
Manuale di manutenzione mentale
Prima di leggere questo articolo, facciamo una breve verifica: una sorta di “tagliando interiore”, sotto forma di checklist (quasi) seria, da consultare ogni qualvolta si attivi la fase di surriscaldamento.
1) Hai spento le notifiche o continui a lavorare dentro al rumore?
2) Casella mail a zero, ma anche le energie? È ora di un riavvio
3) Se la sedia sembra scricchiolare… forse sei tu che hai bisogno di stiracchiarti
4) Ultima pausa mentale: non te la ricordi? Allora è già ora di farla
5) Fissare lo schermo per schiarirsi le idee raramente funziona
6) Il cervello funziona a ossigeno, non a caffè
7) Cinque minuti di camminata risolvono più di un’ora di riunione
8) Multitasking: il modo più veloce per fare tre cose male in una volta sola
9) Il Silenzio non è vuoto: è parte del reset
10) Se stai leggendo questa lista durante una riunione, complimenti: hai appena trovato il minuto più produttivo di tutta la giornata
Se almeno una risposta ha suscitato una riflessione, forse vale la pena indagare più a fondo. Perché ogni giorno l’architettura progetta spazi, verifica impianti, controlla certificazioni e protocolli di sicurezza, ma è davvero in grado di “manutenere” le menti che li abitano? Il cervello, dopotutto, è una macchina di precisione. E come tutte le macchine, se non viene curata, si inceppa.

Pensiero, versione 2.0
L’ingegneria chiama manutenzione preventiva l’insieme delle azioni che servono a evitare il guasto. Tradotto nel mondo del lavoro significa imparare a leggere i segnali prima che diventino blocchi: sovraccarico informativo, calo di attenzione, riunioni senza scopo, multitasking patologico. Altis lavora anche su questo piano, quello della progettazione cognitiva, perché uno spazio funziona solo se chi lo abita è in grado di farlo bene. La manutenzione mentale è a tutti gli effetti un gesto tecnico e umano: una revisione periodica del modo in cui pensiamo, collaboriamo, agiamo.
Lubrificare i circuiti
Come l’olio nei motori, anche la mente ha bisogno di fluidità. Pause brevi e regolari, cambi di postura, luce naturale, micro-movimenti: elementi che il design può favorire e che la neuroscienza conferma come essenziali per la performance. Il pensiero non si rigenera sotto stress continuo: ha bisogno di frizione controllata e di punti di raffreddamento. Spazi silenziosi, routine di decompressione e momenti di ricalibrazione, come un semplice respiro consapevole, sono parte della manutenzione quotidiana.
Riparare senza sostituire
Nell’industria si tende a sostituire ciò che si rompe. Nelle persone, invece, è più intelligente (ed etico) riparare. La manutenzione mentale significa riconoscere gli attriti: un team che comunica male, una leadership troppo “on”, un’organizzazione che non lascia spazio al recupero, e intervenire in modo chirurgico, non punitivo. È un cambio di paradigma: dal culto della produttività alla cultura della durata.
La manutenzione mentale è un atto di cura progettuale che Altis considera parte del metodo: Consult, Design, Deliver, utile anche o soprattutto quando il cantiere è ancora nella nostra mente. Per saperne di più, scrivici a [email protected].
La finestra come orizzonte
Se chiedessimo ad Alfred Hitchcock la sua idea di finestra, probabilmente non si soffermerebbe sull’estetica quanto piuttosto sulla percezione. In “Rear Window” (“La Finestra sul cortile”, 1954) la finestra diventa un varco narrativo: racconta l’ossessione del guardare fuori e l’illusione che ci sia sempre una vita più interessante dall’altra parte del vetro.
E noi, quanto tempo passiamo a guardare fuori dalla finestra? Un gesto universale, che sa di respiro e di libertà, che compiamo per ritagliarci un momento di pausa e di evasione. La finestra, in ufficio come a casa, non è un semplice infisso, è un comando emotivo: il nostro Ctrl+Alt+View. Uno strumento che cambia il modo in cui lavoriamo, pensiamo e ci percepiamo.

L’affaccio come palestra mentale
Il punto è che guardare fuori interrompe la spirale del multitasking e apre uno spazio nuovo. Neuroscienze alla mano: l’affaccio riduce i livelli di cortisolo, stimola la creatività laterale e abbassa la percezione dello stress. Non è un vezzo, ma biochimica. Non a caso le aziende che investono in uffici panoramici ottengono risultati migliori in engagement e performance.
Dal corner office al seminterrato
Ma non tutte le finestre sono uguali. Lo sappiamo: c’è chi si affaccia su skyline da cartolina e chi si ritrova con vista parcheggio o muro di cemento. Eppure, anche qui il cervello fa la sua parte. Qualsiasi collegamento visivo con l’esterno, persino un albero spelacchiato o un corvo sul cornicione, funziona da reminder che il mondo va avanti anche oltre l’Excel che abbiamo davanti agli occhi. E non conta solo il panorama, ma la possibilità di avere un orizzonte, di percepire l’oltre (lo sappiamo, suonerà New Age… ma ha tutta la sua logica).
Quando la finestra non c’è
Se di finestre non ce ne sono, allora l’occhio se le inventa: un graffito sulla parete, uno screensaver tropicale, persino un corridoio illuminato diventano orizzonti sostitutivi. Funzionano? Fino a un certo punto. Senza accesso alla luce naturale e al contatto visivo con l’esterno, la produttività cala e il benessere psicologico si riduce drasticamente. Per questo il tema non è estetico, ma progettuale: ripensare i luoghi di lavoro significa anche decidere come e dove aprire finestre.
La finestra, insomma, è molto più che uno sguardo sul mondo: è un’interfaccia tra dentro e fuori, tra concentrazione e fuga, tra quotidiano e sogno. Non risolve tutti i mali del lavoro contemporaneo, certo. Ma resta un elemento fondamentale del nostro wellbeing quotidiano. Per il resto, vale la lezione di Hitchcock: il fuori che osserviamo è solo un pretesto, perché la vera scena si svolge sempre dentro di noi.
Il cantiere invisibile
Ogni progetto architettonico ha due facce: quella che appare, fatta di forme e materiali, e quella che resta dietro le quinte. Non parliamo di gru e caschetti, ma di quella zona grigia fatta di permessi, incastri logistici, convivenza di squadre di lavoro e gestione degli imprevisti. È il lato invisibile del costruire: quello che non compare nei rendering ma che decide le sorti del progetto.

La burocrazia non è un dettaglio (Ma dai?)
Altro che cemento armato: il vero muro iniziale è fatto di carte bollate, autorizzazioni, normative. Non il pezzo più glamour, certo, ma senza quello il resto non parte. E qui non basta compilare moduli: serve leggere le pieghe del sistema, anticipare le frizioni, usare i vincoli come bussola. In altre parole: il backstage legale è già parte del progetto.
Logistica: il Tetris che nessuno immagina
Un cantiere non è solo costruzione: è una coreografia di materiali, attrezzature e persone. Quando la logistica funziona, nessuno se ne accorge; quando non funziona, tutti se ne ricordano. Il dietro le quinte è un esercizio di sincronia: coordinare fornitori, gestire ingressi, rispettare orari. Un’arte meno tangibile, ma decisiva.
Gli imprevisti non sono imprevisti
In teoria sono ostacoli, in pratica sono la normalità. Ritardi, errori di fornitura, imprevisti strutturali: ogni cantiere li conosce. La differenza la fa la preparazione. Leggere i vincoli in fase di progetto, anticipare le criticità e governarle fino alla consegna è ciò che distingue un approccio meno organizzato da un metodo solido. Noi lo chiamiamo Consult – Design – Delivery ed è efficace perché mette in sequenza ciò che di solito resta scollegato: leggiamo i requisiti reali e le regole del contesto prima di disegnare, progettiamo scelte che semplificano la logistica e riducono gli intoppi, e in consegna coordiniamo tempi, attori e imprevisti come un’unica regia.
Se volete scoprire come Altis tiene insieme il volto visibile e invisibile di ogni progetto, scriveteci a [email protected]
Open Plan, Closed Minds?
Sedie che si girano, scrivanie senza confini e la promessa di un brainstorming perenne. Così è stato venduto l’open space: la soluzione definitiva per rendere le aziende più collaborative, dinamiche, “cool”. E invece? Nella realtà la colonna sonora è fatta di rumore, distrazioni, telefonate in vivavoce e cuffie noise-cancelling come unica forma di autodifesa.
L’open space è diventato lo standard, ma non per questo funziona sempre. Anzi… spesso è vero il contrario.

Il mito della collaborazione perpetua
Negli anni Novanta e Duemila, gli open space hanno incarnato un’idea quasi utopica di ufficio: nessun muro, nessuna barriera, solo colleghi pronti a condividere idee come se fossero caramelle. In teoria, la formula sarebbe: più prossimità = più collaborazione. In pratica, più prossimità = più pausa caffè e chiacchiera. Il mito dell’interazione spontanea si è spesso trasformato in una trappola: l’open plan non garantisce scambio, ma interruzioni.
Rumore bianco o rumore nero?
Il problema non è solo organizzativo, ma cognitivo. Ogni interruzione spezza quelli che possiamo chiamare “cicli attentivi”: uno studio recente di Toggl Blog segnala che servono in media 23 minuti per recuperare la concentrazione persa dopo una distrazione. Moltiplichiamolo per dieci micro-distrazioni al giorno ed è chiaro perché i phone booth sono diventati lo status-symbol dell’open space. La promessa di energia collettiva si trasforma facilmente in rumore bianco, quando va bene, o in rumore nero, quello che brucia tempo e pazienza.
Non open vs closed, ma plural
Il punto non è scegliere tra muri o spazi aperti. La questione è più sottile e sta nel progettare spazi che rispettino i diversi registri cognitivi ed emotivi delle persone: c’è chi ha bisogno di isolamento per concentrarsi, chi di condivisione per generare idee, chi di movimento per trovare energia.
Qui entra in gioco il nostro approccio Emotion Based Working: leggere e progettare gli spazi a partire dalle emozioni che devono sostenere, non dal dogma architettonico del momento. Non esiste un modello unico, ma un ecosistema di possibilità. Stanze chiuse, aree ibride, angoli di privacy, zone fluide: il vero ufficio non è un dogma spaziale, ma un insieme di scelte consapevoli.
Vogliamo accettarlo o no?
L’open space è stato il simbolo di un’epoca, probabilmente passata. Lavorare bene ora significa costruire ambienti che sanno quando aprirsi e quando chiudersi. Perché, alla fine, la vera collaborazione va al di là dalla disposizione delle scrivanie: nasce dalla progettazione di uno spazio che rispetti i diversi modi di pensare e di lavorare.
Se questo tema vi intriga, scriveteci a [email protected], vi promettiamo una conversazione più stimolante di un brainstorming improvvisato davanti alla macchinetta del caffè.
Siete pronti per una nuova era del lavoro?
Settembre: voce del verbo “ricominciare”, ovvero il momento perfetto per rimettere sotto la lente un concetto che da anni fa scuola, l’Activity Based Working (ABW). Bello, flessibile, motivante… sulla carta. Ma cosa succede oggi, nel pieno di realtà ibride e generazioni che vivono il lavoro in modo sempre più soggettivo ed emancipato?
L’avete già notato anche voi, qualche crepa si vede. E visto che, come si suol dire “tre indizi fanno una prova”, abbiamo estrapolato tre dati chiave dalla Ricerca Proprietaria Altis che dimostrano perché è il momento di ripensare il modello così come lo conosciamo.

Primo indizio: dalla flessibilità alla dispersione
L’ABW nasceva con una promessa: più libertà, meno scrivanie fisse, più collaborazione. Ma la realtà post-pandemica ci ha restituito un paradosso: il 55% dei Gen Z dichiara di sentirsi solo o in difficoltà a costruire relazioni sociali ( McKinsey). Se l’ufficio non funziona anche come un collante umano, la flessibilità rischia di trasformarsi in dispersione, perché più libertà non equivale automaticamente a più benessere.
Secondo indizio: produttività sì, ma fino a un certo punto
Gli studi sull’ABW mostrano miglioramenti nell’attività fisica e nella soddisfazione, ma anche piccoli cali di produttività. Insomma, ci muoviamo di più, stiamo meglio… ma lavoriamo davvero meglio? È il classico trade-off: l’ambiente favorisce interazione e movimento, ma senza un disegno calibrato sulle persone, rischia di rallentare i processi invece di accelerarli.
Terzo indizio: il ROI non è più solo immobiliare
Per anni l’ABW è stato adottato per ridurre le postazioni e ottimizzare i metri quadri. Oggi, però, parlare di ROI significa guardare oltre l’occupancy: salute mentale, engagement, qualità delle interazioni. In un mondo ibrido, il vero valore dello spazio non è “quante scrivanie risparmi”, ma “quante connessioni generi”.
La prova: un passo avanti con l’EBW
Ecco perché in Altis parliamo di Emotional Based Working. Non un semplice acronimo da proporre all’Accademia della Crusca, ma un approccio solido, basato sui dati e sulle persone. Alla base c’è la nostra Ricerca Proprietaria, che esplora la relazione tra spazio e comportamento, indagando come l’ambiente fisico influenzi lo stato emotivo e le dinamiche sociali all’interno di un ufficio. È così che ogni progetto si fonda su evidenze scientifiche e su una reale comprensione di come lo spazio possa migliorare benessere e produttività.
Perché il lavoro di oggi è basato sulle emozioni piuttosto che sulla sola attività. Ed è tempo di progettare luoghi che lo riflettano, senza nostalgia per i vecchi modelli, e cogliere un’importante intuizione: il prossimo “upgrade” del lavoro non sarà solo tecnologico, ma anche emotivo.
Il resto della storia? Scriveteci a [email protected]. Ve la raccontiamo. [email protected]. We’ll tell you more.