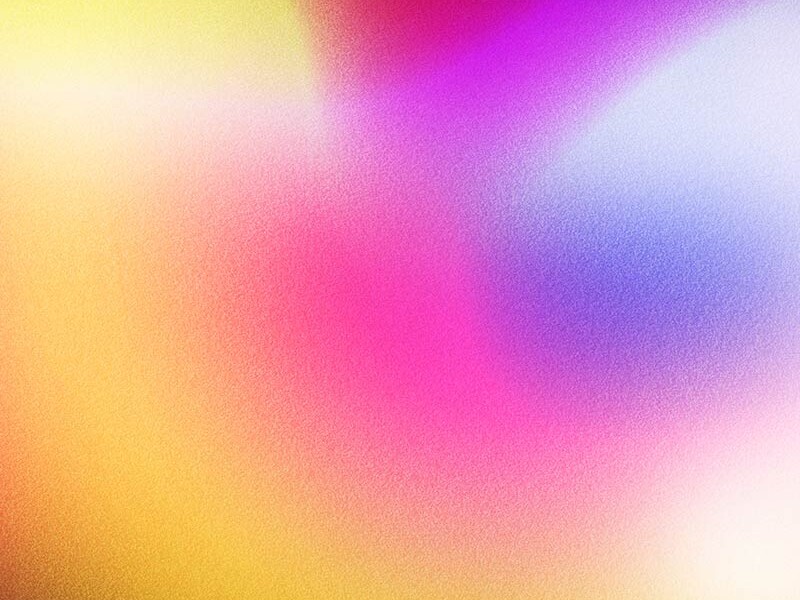In una scena di Will Hunting - Genio Ribelle (1997) un intenso Robin Williams, nei panni dello psicologo, dice a un giovanissimo Matt Damon:
“You’re afraid of what you might become if you let someone in.” Hai paura di cosa potresti diventare se lasci entrare qualcuno.
Non è, solo, una battuta che si riferisce a un genio difficile da domare. È una frase che parla di fiducia: di quanto sia complesso concederla, aprirsi, trovare il proprio spazio. Sul lavoro succede di frequente. Ci muoviamo tra team, call, progetti condivisi, eppure spesso rimaniamo ai margini emotivi di ciò che costruiamo. Perché appartenere significa lasciarsi vedere con la propria voce, vulnerabilità e presenza, ma non sempre siamo disposti a farlo.

Più che empatia: sicurezza psicologica
Ed ecco che torna utile il concetto di psychological safety, coniato nel 1999 da Amy Edmondson, docente di Leadership and Management ad Harvard: la convinzione che un gruppo funzioni meglio quando ognuno si sente libero di esporsi, sbagliare, proporre. Sicurezza, non comfort: non si tratta di eliminare il rischio, ma di creare un contesto in cui il rischio sia sostenibile. Dove la fiducia diventa una piattaforma, più che una promessa. Perché se la paura di essere giudicati blocca l’espressione, la sicurezza di poter contribuire la moltiplica. È proprio da questa consapevolezza che nasce Emotion Based Working (EBW), l’approccio sviluppato da Altis per progettare spazi a partire dalle emozioni che devono sostenere. EBW traduce in metodo ciò che spesso resta intangibile: la relazione tra architettura e stati emotivi. Costruire luoghi in cui sentirsi parte, dunque, significa dare forma a fiducia, empatia e identità condivisa.
Misurare l’imponderabile
Ma quindi si può misurare il “sentirsi parte”? Più o meno, sì. Le neuroscienze parlano di ormoni come ossitocina e dopamina; la psicologia, di motivazione; il marketing di engagement. Ma il vero indicatore resta umano: la disponibilità spontanea a restare, contribuire, prendersi cura. Nei progetti di Altis questo si traduce in spazi che favoriscono l’incontro, ma anche il riconoscimento individuale. Zone comuni, sì, ma anche nicchie personali: perché l’appartenenza collettiva si costruisce solo se ognuno trova il proprio posto, fisico ed emotivo.
Appartenere, in fondo, non è uno stato. È un verbo in continua coniugazione. Un lavoro quotidiano, silenzioso, di cura del contesto. Perché nessun open space, da solo, basta a farci sentire parte di qualcosa, ma uno spazio pensato per le persone può ancora farci dire, con sincerità, “qui sto bene”.
È una riflessione che senti anche un po’ tua? Contattaci a [email protected] e parliamone insieme.